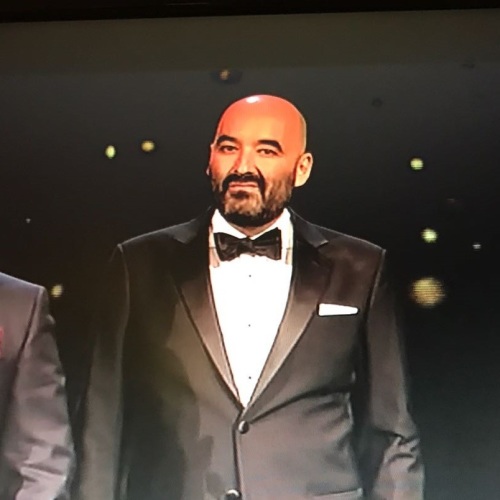Buon compleanno dagherrotipo! Bernoud fotografò i Borbone
– Il 9 di gennaio del 1839, l’Accademia francese delle scienze annunciava l’invenzione del dagherrotipo. Nasceva così il primordiale procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini. Questa tecnica venne inaugurata da Louis Jacques Mandé Daguerre, da cui prese il nome, su suggerimento di Joseph Nicéphore Niépce e di suo figlio Isidoro. Il prototipo venne, invece, presentato pubblicamente dallo scienziato François Arago, il quale oltre l’istituto scientifico parigino intese esporlo anche presso la locale Accademia di Belle Arti.
Dal punto di vista strutturale, il dagherrotipo era composto da una fotocamera, cioè una scatola di legno, dotata di una fessura per la lastra di rame posta sul retro e di un obiettivo fisso, in vetro e ottone, collocato frontalmente; poi, attraverso il procedimento della riflessione andavano a formarsi le immagini sull’apposita lastra. Dopo alcuni accorgimenti, la dagherrotipia cominciò ad ottenere una considerevole fortuna, poiché tramite i suoi sviluppi era possibile riprodurre paesaggi e nature morte. Con il passare del tempo, andarono ad affinarsi i processi esecutivi, tramite l’impiego di nuovi e migliori obiettivi luminosi, che consentirono la duplicazione di ritratti o di soggetti di fotogiornalismo. In molti si avvicinarono a questo strumento, soprattutto i francesi, e la stessa tecnica iniziò a diffondersi anche nel resto d’Europa.
In Italia, la dagherrotipia raggiunse alti livelli grazie all’interessamento di molti artisti e scienziati, ma notevoli contributi giunsero anche da parte di autori transalpini che si erano trasferiti in città come Torino, Genova, Firenze, Roma e Napoli. Presso il capoluogo partenopeo, particolarmente attivo, a partire dal 1856, fu Alphonse Bernoud. Suoi sono alcuni straordinari esemplari di dagherrotipi, conservati in vari musei italiani, ma soprattutto le prime eccezionali foto realizzate con la tecnica del collodio a umido. Entrato in contatto con la famiglia reale, eseguì per alcuni suoi esponenti straordinarie riproduzioni, di cui si ricordano, specialmente, quelli di Ferdinando II e di Maria Sofia di Wittelsbach. Oltre ad essere ritrattista di corte, Bernoud fu anche cronista d’assalto. A lui, difatti, si deve il reportage fotografico dedicato ai devastanti danni verificatesi nel Vallo di Diano a seguito del terremoto del 1857. Fu residente presso la Villa Reale fino al 1864, e continuò a frequentare l’aristocrazia napoletana anche dopo l’arrivo dei Savoia. Nel 1873, fece ritorno a Lione, lasciando a Napoli un patrimonio di riproduzioni fotografiche che, ancora oggi, aiutano a comprendere la storia, le vicende ed i personaggi che caratterizzerono il meridione tutto nella seconda metà del XIX secolo.
Luigi Fusco – Docente di italiano e storia presso gli Istituti Superiori di Secondo Grado, già storico e critico d’arte e guida turistica regione Campania. Giornalista pubblicista e autore di diversi volumi, saggi ed articoli dedicati ai beni culturali, alla storia del territorio campano e alle arti contemporanee. Affascinato dal bello e dal singolare estetico, poiché è dal particolare che si comprende la grandezza di un’opera d’arte.
About author
You might also like
Sei David a “Indivisibili”, Caserta sempre più “piccola Atene”
(Enzo Battarra) – Sei statuette alla 61esima edizione dei David di Donatello per “Indivisibili”, una storia che nasce in provincia di Caserta. Innanzitutto perché il regista è il casertano Edoardo
La World Organization Ambassadors a Caserta, nuove nomine
Maria Beatrice Crisci -Una cerimonia semplice ma solenne a Casertavecchia presso il Boutique hotel Palazzo dei Vescovi. L’occasione la visita del Cancelliere Europeo WAO (World Organization Ambassadors) cavaliere ambasciatore Giuseppe
La biblioteca svelata, focus della Reggia sui libri della Regina
Luigi Fusco – In occasione della Giornata Internazionale del Libro, venerdì 23 aprile la Reggia di Caserta terrà un focus online sulla Biblioteca Personale della Regina Maria Carolina, con l’obiettivo